“Il cappello di Rembrandt” di Bernard Malamud
Otto storie sull’impossibile di tutti i giorni
di Valentina Di Biase / 21 ottobre 2016
«A essere sincero, sebbene abbia fatto resistenza all’idea, mi considero un uomo ansioso, il che, quando cerco di spiegarmelo, significa trovarsi a ogni istante già per metà in quello successivo. Se sto seduto sono impaziente, mi preoccupo inutilmente del futuro, e porto il peso di una coscienza sovrabbondante».
Quando ci si ritrova tra le mani un libro di racconti il territorio da esaminare può diventare spinoso, poiché, risolvendosi in tempi più brevi rispetto al romanzo, necessita di un’idea forte, di una minuziosa cura dei dettagli, di un’accurata selezione delle parole.
Raymond Carver sosteneva di apprezzare nei racconti la chiarezza e la semplicità ma non la semplicioneria, ed è in effetti questo il rischio maggiore che uno scrittore può correre, ma se a comporre una raccolta di racconti è Bernard Malamud il discorso cambia e di parecchio.
Il libro in questione è Il cappello di Rembrandt – pubblicato inizialmente nel 1973 e riportato nelle librerie a quarant’anni di distanza dalla casa editrice minimum fax nella collana minimum classics.
Nei racconti che lo compongono trovano spazio personaggi disillusi, remissivi, perfino cinici che tuttavia non abbandonano mai del tutto l’inclinazione alla speranza, alla possibilità di un finale diverso, inverosimilmente felice, che li salvi dall’abulia delle proprie cattive abitudini, dalla consapevole negligenza del viversi addosso, da se stessi.
Giorgio Fontana nella prefazione sostiene che «L’impossibile, in Il cappello di Rembrandt, permane sempre tale. Nessuno ottiene ciò che vuole, anche perché spesso non se lo merita. Eppure la sconfitta non illumina un mondo cupo e desolato, né si tramuta in accanimento: in ogni caduta c’è sempre una grande dignità».
È il caso del dottor Morris nel racconto “A riposo”, un pensionato che per combattere i demoni della solitudine azzarda goffe avances a una giovane donna avvenente e dai facili costumi, per poi essere mestamente deriso dalla realtà della sua vecchiaia; o dell’insegnante Albert Gans in “La corona d’argento”, che prova con ogni mezzo a salvare il padre ormai prossimo alla morte – spinto soprattutto dai sensi di colpa e da una pietà filiale maturata troppo tardi e troppo in fretta – fino a ricorrere alle dubbie prestazioni miracolose di un rabbino.
Anche qui la conclusione è facilmente supponibile, l’autore non ci lusinga con speranze poco plausibili e dunque la morte arriva, logica e avvilente, a farsi beffa delle debolezze e delle superstizioni di chi resta.
Ma il rapporto conflittuale tra genitori e figli lo ritroviamo anche in “Mio figlio l’assassino”, dove, in poche splendide pagine, emerge tutto il disagio di un padre che non riesce a comunicare e a farsi amare dal figlio chiuso in se stesso e spaventato dalla vita.
«Non puoi sconfiggere gli anni quando ti corrono dietro. Ma se sei in pensiero per un altro, non c’è niente di peggio. È una vera preoccupazione, perché se quello non ti vuol parlare, non puoi entrargli dentro per scoprire il perché. Non sai dove si trova l’interruttore da spegnere. Non fai altro che preoccuparti di più».
Malamud, dunque, in queste otto storie volutamente prive di eventi eclatanti, riesce ad allestire minuziosamente il teatro della natura umana: ogni figura si muove sulla carta in base alle sfaccettature e alle contraddizioni della propria indole, che spesso porta soltanto a una serie di soluzioni inesplose.
Alla fine di ogni racconto al lettore rimane la consapevolezza dell’inevitabile, come se ogni azione compiuta per alterare la condizione iniziale abbia modo di esistere solo nell’inconcludenza.
(Bernard Malamud, Il cappello di Rembrandt, trad. di Donata Migone, minimum fax, 2015, pp. 211, euro 13,50)
LA CRITICA
La bellezza e l’unicità dei racconti di Malamud non deriva tanto dal successo collaudato di un premio Pulitzer, ma dal rispetto e dalla dedizione per ognuno dei suoi personaggi. «C’è una parola per tutto questo, naturalmente, ed è amore».


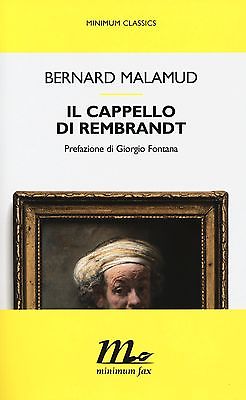



Comments