Carroll, Proust, Joyce e la filosofia della scienza
Un attraversamento continuo
di Claudia Cautillo / 29 gennaio 2020
«Sta assassinando il tempo! Tagliategli la testa!» urla la Regina di Cuori al Cappellaio Matto, e da quel momento l’intero regno si ferma all’ora del tè: le sei, secondo la consuetudine britannica del XIX secolo. Con il suo cosmo rovesciato dove si entra in un nuovo spazio-tempo senza peso né numero, Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie (1865) e Attraverso lo specchio (1871) sembrano sorprendentemente anticipare Willem de Sitter e le sue porzioni di universo in cui il tempo è immobile, così come altre folgoranti scoperte della fisica dei decenni seguenti. Connessione tra scienza e letteratura – a partire da teoria dei quanta di Planck, equazioni della relatività di Einstein e psicologia del profondo di Freud – che Giacomo Debenedetti, nel fondamentale saggio Il romanzo del Novecento (1971), spiega come rappresenti ciò che Haftmann chiama «un nuovo sistema di coordinate dell’uomo nel mondo», indispensabile per comprendere opere potentemente innovative quali La Recherche (1913-1922) di Proust e l’Ulisse di Joyce (1922), basate sul gioco di una realtà ormai non più calcolabile ed esprimibile secondo l’antica legge di causa ed effetto.
La modernità, infatti, è pervasa dall’idea della connessione, dell’attualità, della contemporaneità, dell’intreccio di cose e avvenimenti nel continuum spazio-temporale di un universo relativizzato, tanto quanto il Medioevo da quella del rimpianto per un Eden perduto nel passato e l’Illuminismo dallo slancio progressista verso il futuro. Mai, nelle epoche precedenti, l’Erlebnis era stata una cosa sola con la consapevolezza del presente, quel confluire immanente e sincronico della coscienza che in Durata e simultaneità (1922) Henri Bergson, riferendosi alla teoria della relatività di Einstein, definisce la simultanéité des états d’âme.
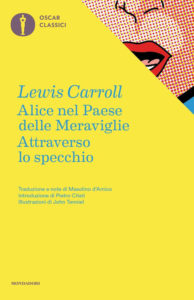
Secondo A.N. Whitehead «il divenire della natura», cioè la forza creatrice dell’esistenza – quello che per Bergson è il tempo – alla luce delle acquisizioni della scienza e della tecnica non possiamo ormai che «immaginare attuale nel tutto, tanto nel più remoto passato quanto nel più piccolo tratto di qualunque durata presente; forse anche nel futuro non ancora realizzato. Forse anche nel futuro che potrebbe essere, oltre che nel futuro che sarà», come espone chiaramente in Il concetto della natura, (1920). «Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato / mirano a un solo fine / che è sempre presente. Eco / di passi nella memoria giù per il corridoio / che non prendemmo verso la porta / che non aprimmo mai / nel giardino delle rose» scrive di rimando T.S. Eliot nel Burt Norton (1935).
Per comprendere il carattere rapsodico della moderna letteratura – a partire dai due giganti del XX secolo, Joyce e Proust – è cioè necessario considerare che, se «il mondo è un pullulare continuo e irrequieto di cose, un venire alla luce e uno sparire continuo di effimere entità […] dove esplodono universi, lo spazio sprofonda in buchi senza uscita, il tempo rallenta» – come ci spiega Carlo Rovelli in Sette brevi lezioni di fisica (2014) – ciò oggi vale tanto più per l’arte che per il nostro proprio universo che ciascuno di noi, minacciata ogni visione unitaria della vita, crea e ricrea incessantemente a sua misura.
Difatti ecco che per il reverendo Carroll lo spazio si sfalda, il tempo non esiste e le cose si dissolvono: Alice cresce smodatamente poi rimpicciolisce, per raggiungere un luogo si deve voltargli le spalle, per restare fermi bisogna correre, le torte vengono prima distribuite e poi affettate, ecc.; mentre in Proust questo fluire imprevedibile della vita nel qui e ora della percezione personale arriva ad assumere un’elasticità tale da farlo coincidere – ci dice Curtius in Marcel Proust (1925) – con ciò che il grande saggista tedesco chiama la durée réelle, la durata reale, vale a dire l’intera realtà dell’anima, tanto da renderci non solo relativa, ma addirittura indifferente qualunque cronologia degli avvenimenti.
Nella Recherche, infatti, il Narratore non dà mai alcun cenno di date o di età né riguardo a se stesso, né nei confronti dei circa duecento personaggi e della mole delle vicende che vi si snodano a comporre la complessa trama. Bambino o adulto, Proust sembra dirci che ciascuno vive sempre la medesima esperienza, il significato della quale non scopre se non dopo molti anni dall’averla vissuta e sofferta, e senza che riesca a distinguere i sedimenti del passato da quel che porta in sé l’ora attuale; in ogni istante della vita si è sempre lo stesso malato, lo stesso individuo solitario, lo stesso giovane dalla sensibilità inquieta. «Non si svolgono forse tutte le nostre esperienze contemporaneamente? E questa simultaneità non è proprio la negazione del tempo? E non è questa una lotta per recuperare quel mondo interiore che va perduto nello spazio e nel tempo?» osserva a questo proposito Arnold Hauser in Storia sociale dell’arte (1951).
Ma se con Proust tutta la realtà diventa contenuto della coscienza e le cose acquistano significato unicamente nell’esperienza psichica, oltre il corso univoco e irreversibile del tempo matematico, l’Ulisse di Joyce si spinge fino a rinunciare tanto alla trama che al protagonista stesso. Niente più fluire degli eventi ma solo scorrere dei pensieri e delle associazioni in un interminabile, continuo monologo interiore in cui il vero eroe del romanzo non è questo o quel personaggio, piuttosto il giorno in cui si svolge – sorta di summa della cultura occidentale nel modo in cui si riflette in una giornata qualsiasi di una metropoli – quel 16 giugno 1904 che ci restituisce dunque la durata eterogenea, la stupefacente, immanente, caleidoscopica immagine di una dimensione disgregata.

Sia Joyce che Proust, di fatto, basano Ulisse e Recherche su un continuum disomogeneo, sull’immanenza del passato nel presente, sul costante congiungersi di vicende, ricordi e sensazioni in quel fluido amorfo che è l’esperienza interiore, sulla relatività di spazio e tempo, ovvero sull’impossibilità di discernere e spiegare in quale mezzo il soggetto si muova e agisca, così come nella realtà sottoterra od oltre lo specchio di Alice – libro filosofico quanto esoterico – con felice intuizione è già preconizzata un’analoga dissoluzione di persone e cose nell’atmosfera eternamente contingente di un sogno, ora meraviglioso ora sinistro.
Sospesi senza esserne consci tra sonno e veglia, i personaggi del soprammondo di Carroll in qualche modo anticipano la spazializzazione del tempo allo stesso modo dell’attualizzarsi e temporalizzarsi dello spazio, che saranno in seguito tema centrale delle opere di Proust e Joyce. Qui, varcata la soglia al di là dello specchio diventato morbido come nebbia, la Regina Rossa costringe Alice a correre con lei a perdifiato: «“Ci siamo quasi! L’abbiamo passato dieci minuti fa! Più svelta!”. “Ehi, ma secondo me siamo state tutto il tempo sotto quest’albero! È tutto esattamente com’era prima!”» Esclama stupita la bambina, quando dopo una lunga corsa finalmente si fermano: «“Certo! Perché, come dovrebbe essere?”» le risponde la Regina, e alla spiegazione razionale di lei su come accada sulla Terra, replica soavemente che nel suo regno, invece, per restare nello stesso posto devi correre più che puoi, e se vuoi andare da qualche altra parte devi affrettarti almeno il doppio. Stessa cristallizzata condizione spazio-temporale vissuta dal Cappellaio Matto, che rimpiange nostalgicamente l’epoca in cui, non ancora bloccato per sempre alle sei del pomeriggio, aveva il potere di far passare velocemente le ore oppure arrestarle di colpo, o a comando imporre ai minuti di tornare indietro.
Tale compresenza del carattere spaziale che assumono le dimensioni temporali, e viceversa, nell’Ulisse e nella Recherche arriva ad assumere una corposità e un’evidenza per cui non esistono più tempo taciuto né spazi vuoti alla coscienza, in quanto tutto è diventato coscienza, vale a dire durata mutevole e informe, in cui ogni cosa si smaterializza per scomporsi e ricomporsi, ma senza che vi sia una separazione tra dimensione dell’autore o dei personaggi e tessuto della narrazione. Non si pone cioè più un’Alice esterna alle vicende, spettatrice distaccata di quel Paese alla rovescia dal cui sogno alla fine si sveglierà, limitandosi a considerarlo il ricordo di «un dorato pomeriggio».
Diversamente, l’hic et nunc destoricizzato di Leopold Bloom o della moglie Molly, allo stesso modo che del Narratore proustiano, è pura energia psichica divenuta atomo, particella infinitesimale della costruzione letteraria e insieme vissuto personale, per cui da essa inscindibile. La giornata-Odissea di Bloom – non singolo personaggio ma insieme composito di sé frammentati – non descrive la vita dal di fuori, è la vita stessa nella consapevolezza di un qui e ora in cui i piani del raccontare si intersecano e mutano velocemente, senza soluzione di continuità, in una sorta di universalismo che non fa distinzione tra protagonisti e comprimari, io narrante e racconto.
Simile voce interna all’opera narrata, pertanto tutt’uno con essa, così come immediatezza e commutabilità dei contenuti dell’interiorità – alberi, campanili e tazze di tè – sottratte alla temporalità ed eternate in un enorme deposito di oggetti, presenze, ricordi, apparizioni, azioni, che il Narratore proustiano dissolve in uno sgorgare inarrestabile in cui ogni attimo è privilegiato: perduto, mai immobilizzato, perché risorge nel momento in cui lo si ritrova, confluire sincronico e immanente dei dati della percezione che costituisce l’essenza della modernità.






Comments