La fantascienza dell’inconscio è vera fantascienza?
Un possibile sguardo
di Enrico Picone / 14 gennaio 2021
Dal Sense of wonder alle speculazioni sociologiche maturate in seno agli autori della New Wave, al genere fantascienza si riconoscono quasi esclusivamente finalità di intrattenimento. Chi guarda alla componente scientifica riconosce loro un certo spessore contenutistico, vedi i fedelissimi di Clarke, chi invece guarda alla componente fantastica riconosce loro un certo spessore letterario, vedi i fedelissimi di Vonnegut. Ma non è mai abbastanza per consacrarla come componente genetica fondamentale della tradizione artistica universale. I manuali di storia della fantascienza individuano la sua origine storica a partire dalla seconda metà del XIX sec., quando gli scrittori furono chiamati a interpretare gli effetti sociali della impetuosa e straordinaria rivoluzione industriale. L’inventiva degli artisti si impregnava di nuove fantasie, la miscela di paura e desiderio – gli stati d’animo da sempre predominanti nell’arte – forniva rappresentazioni e profezie che collocavano l’uomo al centro di immaginari inesplorati e soprattutto inesplorabili, in quanto di natura tecnologica e psicologica.
Gli autorevolissimi autori e cultori della fantascienza non ignorano di certo l’epica e i suoi epigoni, né tantomeno ignorano la sua universalità. Tuttavia non possono non adottare quel limite storico che altrimenti li costringerebbe a una trattazione enciclopedica sul genere. La nuova rivoluzione industriale provocò innegabilmente una rivoluzione della fantasia e delle sue manifestazioni artistiche. A ogni spartiacque storico corrisponde da sempre uno spartiacque artistico. Chi vuol ripercorrere la storia della fantascienza, sa che troverà Wells ad attenderlo alle porte dell’arena letteraria per assistere al folle gioco del progresso. Tripodi alieni, viaggiatori del tempo e uomini invisibili si preparano a uno scontro sovreccitante.
Non ci si può però limitare a misurare la fantascienza come manifestazione letteraria del fascino che gli scrittori provarono per il progresso tecnologico. La fantascienza è un insieme talmente grande da contenere gran parte della produzione artistica universale, e ce ne rendiamo conto ogni qualvolta leggiamo opere che non sono interessate alla tecnologia né alle riflessioni sociologiche sottese, ma che vogliono far luce sulla dimensione più oscura e inaccessibile: l’abisso dell’inconscio. I confini della fantascienza si dilatano allora fino a spezzarsi, perdendo l’essenza stessa di genere letterario. Harold Bloom ha investito non poche energie per rammentare che il solo destinatario della letteratura non sono le cause oggetto delle scienze sociali, bensì l’Io. Talvolta, il confine tra fantascienza e letteratura intesa come intima confessione del proprio voyage introspettivo si rende talmente sottile – e relativo – che si potrebbe perfino dire che la fantascienza non esiste. Alcuni artisti hanno messo al servizio del proprio genio il coraggio di patire il sentimento dell’inquietudine tutte le volte che hanno cercato la risposta alla domanda: “Cos’è la realtà?”. La mostra delle atrocità di Ballard (Feltrinelli, 2001) non è forse una lettura di riferimento al pari de Il mito tragico dell’Angelus di Millet di Dalì o de La riscoperta della mente di John Searle? Pasto nudo di Burroughs non è forse una di quelle opere di genio che sfidano la questione wittgensteiniana del linguaggio? Lungi dal considerarle mere forme di intrattenimento, moltissime opere di fantascienza concorrono a formare un laboratorio di onironautica e analisi introspettiva.
La fantascienza è diffusamente considerata come genere popolare, termine che vuole descrivere la composizione del pubblico al quale questo tipo di letteratura si rivolge: non elitario e dalle aspettative non proprio dannunziane. Ciò lo si deve alla gran mole di racconti che hanno arricchito la tradizione, gravando però sulla qualità media delle opere. Al netto dei grandi maestri, e prima che divenisse un fenomeno culturale in senso stretto, la fantascienza era prodotta da autori mediocri e rivolta a un pubblico culturalmente mediocre. Ecco come la pensava a questo proposito Kurt Vonnegut nel 1980: «Mi sembrava che gli autori di fantascienza scrivessero sui più grandi quesiti del nostro tempo. Mentre gli scrittori più in voga e quelli più rispettati dai critici si stavano ancora confrontando con le sottigliezze del carattere umano, le motivazioni e tutto il resto. E nel frattempo avevamo creato queste macchine mostruose che stavano avendo molta più influenza su di noi di qualsiasi altra cosa… forse questi soggetti non sanno scrivere così bene, ma di sicuro parlano di cose di cui bisogna parlare».
Ricercando nella nebulosa degli autori, si vuole riportare alla luce un nome autorevolissimo del genere, e che in Italia ha riscontrato sempre un particolare successo: Robert Sheckley. In rete non si trova abbastanza da compiacere chi vuol sapere vita morte e miracoli di questo autore. Roberto Quaglia lo ha intervistato nel 2004, un anno prima che morisse. Questa ripresa amatoriale non ha nulla in comune con l’attenzione mediatica riservata ai grandi autori. Sia chiaro che Robert Sheckley figura in tutte le trattazioni di fantascienza degli anni Cinquanta e Sessanta, non è di certo un autore di nicchia.
![]()
Il suo stile è popolare, ma non per questo mediocre. Non vi sono picchi stilistici o intrecci sintattici barocchi. Leggere un racconto di Sheckley equivale a lasciarsi trasportare su un tapis roulant che attraversa pianeti lontani e perfino il confine con l’aldilà. Lo si potrebbe considerare il fratello minore di Vonnegut: minore la fama, minore il genio che muove la penna. Ma come Vonnegut riesce a far sorridere il lettore e a lasciare l’amaro sapore della commozione che si cela nell’ispirazione di tutti i grandi scrittori. Nella sua scatola dei personaggi, Sheckley non tiene più di due o tre modelli, la caratterizzazione del protagonista è quasi sempre la stessa, e lo spessore psicologico del protagonista è tanto sottile quanto tenero. La forma non viene sacrificata, perché non viene anzitutto ricercata. Ci sono argomenti enormi da trattare e Sheckley non vuole farsi esponente di alcuna corrente letteraria, piuttosto sposa la causa comune a tutti gli autori di fantascienza: la sensibilizzazione.
Eppure, nel 1975 Sheckley pubblica Opzioni (Mondadori, 1976), un romanzo che rientra a pieno titolo tra le opere che scelgono come destinazione l’Io. Rispetto all’assordante coro di voci baritone come quelle di Ballard, Burroughs e Philip Dick, la voce di Sheckley è paragonabile al frinire di una cicala sperduta in un incrocio di Nuova Delhi all’ora di punta. Ma chi ha la fortuna – e il coraggio – di attraversare l’incrocio, non può fare a meno di raccogliere la cicala e portarla in un luogo appartato per sentirne la voce.
L’astronauta Tom Mishkin è costretto ad atterrare su un pianeta vicino a causa di un’avaria. Il pianeta funge da deposito di pezzi di ricambio, i quali sono volutamente sparsi sulla superfice per scongiurare il rischio che una calamità possa distruggere il magazzino e con esso tutti i pezzi contenuti. Mishkin deve cercare da sé il pezzo di ricambio, ma viene accompagnato da un robot programmato per guidare e proteggere i clienti del deposito. L’avventura che segue è ovviamente omerica, e la coppia donchisciottesca. La prima minaccia, un grosso animale che «sembrava un’allucinazione bieca, famelica e priva di scrupoli» svela l’inesperienza del robot, il quale scopre di essere stato programmato per affrontare le minacce di un altro pianeta. Sheckley ci regala allora perle come questa: «Quello che uno sa non si adatta ai suoi bisogni. Ciò che ci serve è sempre qualcosa di diverso, e il saggio costruisce la sua vita intorno a questa consapevolezza dell’inutilità delle cose che si conoscono». A proposito di stile lineare ma non mediocre, in Opzioni il ritmo è frenetico e la percezione del tempo è distorta, la personalità del protagonista barcolla tra dubbi esistenziali e quesiti fondamentali. L’animale li attacca, i due riescono a scamparla ma Mishkin batte la testa e perde i sensi. Poi rinsavisce: «Ho conquistato la realtà, adesso sto bene. Cos’è la realtà? […] Una delle tante illusioni» dice il robot. Mishkin scoppia a piangere. «Voleva una realtà esclusiva – scrive Sheckley – così era terribile, peggio di prima. Adesso tutto…» Puntini di sospensione e il respiro della storia si appesantisce, la sua consistenza è lisergica, le digressioni psichedeliche. Riecco allora un altro mostro: «la bocca del serpente secerneva fantasie. Il suo respiro era pura illusione. I suoi occhi erano ipnotici e i movimenti delle ali lanciavano incantesimi».
C’è spazio anche per un colpo di genio. Sheckley manda in scena l’Uomo dei Mille Travestimenti, alias se stesso alle prese con le sventure del suo protagonista per le quali si sente responsabile: «Caro Tom, ho tentato tutto quanto stava nelle mie possibilità per farti avere il pezzo di ricambio e toglierti da quella situazione imbarazzante di cui mi assumo tutta la responsabilità. Sono arrivato al punto di creare una nuova trama, con logica impeccabile e personaggi plausibili. Ma il mio nuovo protagonista ha preso la peste, perso l’interesse per la vita e rifiutato recisamente di portare a termine l’incarico per cui l’avevo creato». Il finale? Un bambino gioca in giardino con una scopa e una vecchia radio. La scopa è Mishkin, la vecchia radio il robot. La madre gli ordina di rientrare in casa, lui risponde: «Non posso, ho bisogno di un pezzo di ricambio per l’astronave».
In Opzioni, Sheckley rispetta i canoni letterari dell’assurdo e li integra con la sua inventiva. Un vortice narrativo psichedelico inghiotte il lettore, al quale non resta che chiedersi “Cos’è la realtà?”. Domanda che rende impossibile intendere la fantascienza come insieme di racconti che vogliono descrivere realtà diverse dalla nostra. Non resta che domandarci “Cos’è la fantascienza?”.


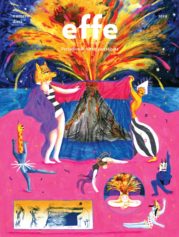


Comments