Cronaca esistenziale di una diserzione
“Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani
di Niccolò Amelii / 9 novembre 2021
L’ultima prova narrativa di Marino Magliani – Il cannocchiale del tenente Dumont, edito da L’Orma nel maggio di quest’anno – è un romanzo ibrido, inserito perfettamente all’interno di una cornice storica, ma che del romanzo storico problematizza l’assunto di fondo. Questo perché, pur presentandosi come la cronaca della diserzione di tre soldati napoleonici datisi alla macchia durante la battaglia di Marengo (battaglia che sembrava persa la mattina e che vide i francesi, poi, sorprendentemente vittoriosi grazie all’aiuto tempestivo delle truppe del generale Desaix), la fonte principale del resoconto è proprio uno dei tre fuggiaschi. Si tratta del tenente Dumont, giovane sognatore la cui realtà – la realtà della fuga forsennata attraverso l’entroterra ligure – non può combaciare né con una pretesa ed esaustiva veridicità dei fatti accaduti, né con la realtà dell’inseguitore, il dottor Zomer, chirurgo olandese che si è messo sulle tracce di Dumont e dei suoi compagni di viaggio – il soldato basco Urruti e il capitano Lemoine – per un’operazione di monitoraggio medico-scientifico. I tre, infatti, non sono dei semplici disertori, perché, dopo essere venuti a contatto per la prima volta con l’hascisc sulle rive del lago Mareotis, ne hanno fatto incetta per il loro ritorno in Francia. Zomer, convinto che uno dei motivi principali dell’alto tasso di diserzione dell’esercito napoleonico in Egitto sia dovuto proprio all’assunzione di questa droga appena scoperta dai francesi, ha il compito di pedinarli, studiarne il comportamento e prevenire una sua ulteriore diffusione tra la popolazione.
Con una scrittura elegante e preziosa, capace di armonizzare anche il lessico tecnico di matrice bellica e marittima, Magliani tesse la trama di un romanzo d’avventure che è al contempo diario di bordo dal sapore ottocentesco e racconto dalle tinte poliziesche, gravitante intorno a un’indagine, a un inseguimento prolungato che, con tutto il suo bagaglio di spie, staffette, avvistamenti e informatori, parte dai deserti di Jaffa per concludersi successivamente sulla frastagliata costa ligure. La narrazione d’ampio respiro, che s’innesca dunque a partire dall’espediente della testimonianza derivativa, innervata da una prosa di afflato classicheggiante scheggiata da brevi e però intense immagini liriche, è introiettata all’interno di un’architettura sintattica moderna, a tratti convulsa, refratta, sussultoria, abile ad esprimere mimeticamente le svolte repentine o le lunghe pause di timore e attesa che caratterizzano la fuga dei tre personaggi.
La struttura dell’opera, internamente frammezzata dai rapidi salti temporali che scansionano la parabola cronologica degli avvenimenti rispondendo all’istanza memorialistica che informa velatamente tutto il testo, richiama, anche in virtù delle precise contestualizzazioni geografiche, le tradizionali costruzioni cinematografiche, attente a far sì che lo spettatore abbia sempre familiarità con i luoghi e i tempi entro cui si dipanano le scene del film. Al piano principale dell’azione diegetica – il tentativo dei tre fuggiaschi di scappare sani e salvi dall’Italia –, si affianca un’ulteriore stratificazione testuale, composta dall’inserzione rapsodica di appunti, lettere, documenti vergati dal dottor Zomer, che contribuisce all’ispessimento di un testo che via via si trasforma in palinsesto, arricchendosi di voci, personaggi, incontri, paesaggi. Il racconto si sviluppa, allora, su più livelli simultanei: la parte principale dedicata alla sorte dei disertori viene alternata alle digressioni (come abbiamo visto, di carattere metanarrativo) riguardanti l’investigatore che li segue e tenta di braccarli, aprendo l’opera a una dialettica interna avvincente e calibrata (avvincente perché ben calibrata, verrebbe da dire), in cui sono certamente i dialoghi tra i tre protagonisti a fare la differenza, a delineare la ragnatela dei movimenti, a imprimere nella mente del lettore la fisionomia dei personaggi stessi, il loro modo peculiare di intendere la fuga, ciò che per loro rappresenta e ciò che immaginano ne conseguirà.
Inoltre, si presenta un ulteriore allargamento dicotomico, anch’esso centrale per le finalità romanzesche, che pone al fianco della Storia ufficiale, quella delle battaglie e delle campagne napoleoniche, non solo la storia individuale di Dumont, Lemoine e Urruti, ma anche e soprattutto la storia minuta di coloro su cui nei libri non ci si sofferma spesso, i braccianti, i contadini, i mulattieri, abitanti silenziosi di una terra aspra e rocciosa, questa Liguria che Magliani conosce a menadito e che, erede della lezione di Boine prima e di Biamonti poi, tratteggia con pennellate rapide, precise ed evocative, dalla forte componente espressiva e visionaria.
Nel gioco reiterato di fatti e controfatti, tra sospetti reciproci, ambiguità velate, timori ancestrali, a emergere prepotente è la malinconia del disertore, che sembra diventare, superate le contingenze primarie del testo, condizione esistenziale di portata universale, suscettibile d’essere declinata secondo moti soggettivi che non perdono però la loro carica di attualità e veridicità. La paura dell’ignoto, che si somma alla paura costante di non farcela, di essere traditi spiati inseguiti braccati, esplode all’interno di uno spazio inospitale che sembra essere il correlativo oggettivo dello stato d’animo dei tre fuggiaschi, assecondando lo scorrere di un tempo ipnotico, che pare continuamente tornare su sé stesso, come se la diacronia interna al romanzo, dismessa ogni assurda pretesa di linearità, fosse diventata ciclica, condizionata dalla stanchezza degli stessi personaggi, dal logorio dei loro tentativi di mettersi in salvo, dalla ripetitività dei gesti, dei rumori, delle sortite, dei dialoghi a mezza bocca.
Ecco, allora, che da cronaca di una diserzione, Il cannocchiale del tenente Dumont si trasforma gradualmente in una “variazione sul tema” della diserzione, declinata in tre differenti modi dai diversi personaggi, abitata sotterraneamente da una tensione interrogativa, al contempo psicologica e sentimentale, che punta a scavare nell’animo di chi, ormai stremato, incerto, dubbioso su ogni futura mossa, continua a guardare il mondo attraverso “il rumore dell’occhio”, quel cannocchiale, appunto, che il tenente Dumont utilizza con assidua frequenza per spingersi oltre l’orizzonte naturale che gli si frappone davanti e tentare di accedere a chissà quale visione epifanica, forse di una realtà altra, di un destino diverso, libero, lontano dai pedinamenti, dalla fame, dalla guerra. La bellezza di questo romanzo risiede proprio qui, in questo crescente slittamento costitutivo. Da supposto resoconto oggettivo il romanzo di Magliani – romanzo di geografie visive e di geografie interiori a cui l’autore lavorava da vent’anni – diviene via via racconto esistenziale, riflessione sul senso delle proprie azioni, della pietas umana, nonché una verifica narrativa sulla possibilità di recidere o meno i legami col proprio passato, di fuggire dalle maglie oppressive e traumatiche della Storia.
(Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont, L’Orma, 2021, 296 pp., euro 20, articolo di Niccolò Amelii)


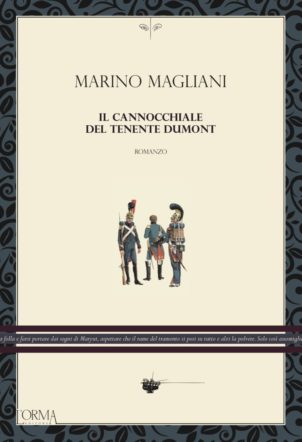



Comments