Teratophobia del sangue: la paura di generare mostri
“Cos’hai nel sangue” di Gaia Giovagnoli
di Alberto Paolo Palumbo / 11 maggio 2022
Si definisce teratofobia la paura immotivata dei mostri e delle persone deformate. In medicina, ci si riferisce in particolar modo alle donne in gravidanza che hanno paura di partorire figli deformi, soprattutto quelle che hanno sofferto di rosolia e altre malattie che potrebbero creare malformazioni al feto.
Teratophobia (‘Round Midnight, 2018) è anche la prima raccolta poetica della riminese Gaia Giovagnoli, in cui la teratofobia diventa in senso metaforico la paura del mostruoso che si annida dentro la profondità del sé e nella materia del corpo. È la paura di conoscere ciò di cui siamo realmente fatti, i nostri errori e quelli delle generazioni a noi precedenti, e soprattutto di confrontarsi col dolore degli altri, come recitano i seguenti versi tratti dalla raccolta:
«Il chiodo dice cosa strazia: / ha aperto un nodo / come un tuffo l’acqua / Il chiodo tocca il buio / e dice del mostro: / se vuoi sentire di me / leggi nel sangue // – che dal sangue biforco / come rami di un cervo: / la debolezza fatta osso spino / a bucarmi la testa: / un’impotenza che è corona / che innalzo».
Questi versi sembrano il punto di partenza ideale per parlare di Cos’hai nel sangue (nottetempo, 2022), esordio alla narrativa di Giovagnoli, un’opera prima dove si fondono quelle realtà e suggestioni fantastiche che hanno portato Nicola H. Cosentino, nella sua recensione al romanzo per La Lettura, a collocarla nel filone del New weird italiano – o meglio, del “Novo Sconcertante Italico” – poiché «compatta brividi pop vecchi e nuovi, tra L’isola del dottor Moreau e Stranger Things per poi condurci dalle parti dell’Area X di Jeff VanderMeer».
Cos’hai nel sangue si apre con un’immagine dal forte impatto visivo e onirico, che potrebbe ricordare la scena iniziale del taglio all’occhio della donna di Un chien andalou di Luis Buñuel: un sogno raffigurante una donna, «la madre», distesa nella stanza con «la carne spalancata come quella di un coniglio», e una bambina che la cerca nel buio. Quella «ferita, umida e scura» è la vagina della donna, che si presenta come uno squarcio nella mente di chi quel sogno l’ha concepito, ovvero la protagonista Caterina. La ragazza, infatti, ha ancora una ferita aperta: il rapporto irrisolto con sua madre, la signora Gaggi, che conosceremo nel corso del romanzo come Cariclò. Questo legame complesso è strettamente connesso a un segreto nascosto da tempo e che riaffiora con l’arrivo a casa delle donne dell’antropologo Alessandro Spina. Il segreto riguarda il passato di Cariclò e il suo paese, Coragrotta, un inquietante borgo isolato dal resto del mondo che tanto ricorda il Carcosa di True Detective, dove si svolgono riti ancestrali e aleggia una maledizione di cui l’artefice si rivelerà essere Fara, la nonna di Caterina.
Il rimando alla poesia è molto forte, e si può rintracciare negli eserghi che Giovagnoli utilizza all’inizio della prima e della seconda parte del romanzo, tratti rispettivamente da Descending Figure di Louise Glück e The Journals of Susanna Moodie di Margaret Atwood. Entrambi anticipano i temi del sogno e dei conflitti irrisolti col passato, spesso rappresentati come mostri – o meglio, animali, come recita l’esergo di Atwood. Il romanzo è anche intriso di suggestioni alimentate dalle tradizioni popolari e dall’antropologia, retaggio degli studi universitari dell’autrice. Lo si nota sia nella struttura dei capitoli dedicati ad Alessandro Spina, scritti come fossero un vero e proprio diario di un antropologo, che nei rimandi a santa Caterina da Siena e alla storia – presumibilmente inventata – della strega Caterina Foschi, bambina di tredici anni del Casentino che, in alcuni documenti datati 1567, si legge sia stata accusata di stregoneria.
Gaia Giovagnoli è riuscita a creare un immaginario sospeso fra la realtà e il sogno. Si pensi, per esempio, proprio alla figura di Caterina Foschi, i cui elementi principali sono stati mutuati da santa Caterina da Siena: il rifiuto del cibo, l’alimentarsi con le ostie, la morte per stenti diventano elementi di stregoneria associati a un rito attorno al quale ruota la società di Coragrotta:
«[…] la natura di Coragrotta è questa e non può essere altro: gli uomini sono stupidi e servono per il loro sperma, le donne invece partoriscono bambini, vivi o morti che siano. Tutto qua. E se non riesci ad accettarlo, se quel posto ti fa venire la nausea, se provi a immaginare qualcosa di più oltre agli alberi, ai corpi sudati, alla vergogna di aver fatto un figlio morto, non cambia nulla. Coragrotta è questo e lo sarà sempre».
A Coragrotta, infatti, le donne usano gli uomini, chiamati “svardùni” e ridotti allo stadio di animali da monta, per procreare e abortire i bambini che concepiscono – i «morticini», sepolti ai piedi del Monte Sospiro, da cui nascono i «lupi nudi», gli spiriti dei bambini mai nati. Il rito della Caterina santa e strega che rifiuta il cibo e che allo stesso tempo si nutre di ostie risulta essere, come sottolinea Spina, «una narrazione co-creata da entrambi i generi e molto radicata» a Coragrotta, che nasconde la paura di generare – qui da intendersi metaforicamente – mostri, ovvero il dolore della coscienza del proprio corpo e della possibilità di provare piacere da esso, lo stesso che alimenta Cariclò:
«La verità è che non sapeva di sé perché nessuno gliel’aveva mai detto com’è fatta. Aveva fatto sesso, era rimasta incinta, aveva partorito – e nessuno le aveva mai spiegato niente. Lei non aveva mai osato chiedere. Aveva scoperto tutto quanto da sola, e inventato dove non poteva capire – e deve aver subìto tutto, con una sorta di violenza sottile. Il suo pudore, come un’ulcera, era stato prima caos poi era marcito, diventando turbamento. Paura. Il corpo, tutti i corpi – lo capisco solo ora – le fanno paura».
La violenza dei corpi e la pulsione carnale sono ciò che nascondono le donne di Coragrotta, ma l’arrivo di Spina a casa di Caterina e Cariclò e il sogno della protagonista riaprono questa ferita e portano il mostro a uscire dal loro inconscio. Questo aspetto della rivelazione del sé attraverso il proprio corpo è stato già affrontato da Giovagnoli in un’intervista rilasciata a Claudia Tedeschi per Una / kοινῇ*:
«[…] il mostro nasce quando […] si capisce che la propria vita, il proprio corpo, il proprio alfabeto, sono elementi particolari e isolati, fallibili. Il mostro sorge quando qualcosa – un trauma, una ferita, una malattia, altro – ci forza alla consapevolezza e ci obbliga a vedere che quel quotidiano che si dava per scontato è in realtà costantemente sotto attacco. Cede di continuo. Non è così solido come si credeva».
Il sogno di Caterina e il risveglio dei ricordi di Cariclò costituiscono il trauma e la ferita a cui fa riferimento l’autrice, il richiamo del «paese che ti rivuole», «il chiodo che dice cosa strazia» e invita «a leggere di me nel sangue» dei versi citati prima da Teratophobia. Caterina afferma di «credere di fare delle cose per rispondere a desideri miei, quando in realtà sono solo una risposta a lei». Caterina è il mostro nel senso di monstrum, ovvero di “prodigio” e “rivelatrice”. Lei è venuta al mondo per portare Cariclò ad accettare la verità: i nostri sono corpi fragili, generano dolore, necessario per conoscersi e per vivere. La consapevolezza che fa sì che la maledizione di Coragrotta possa risolversi è la seguente: come Caterina è sia la santa che la strega, così le donne protagoniste e tutti gli abitanti di Coragrotta comprendono che accettare la propria carne e il proprio sangue significa accettare la ferita, la violenza, gli errori passati e quelli futuri.
Cos’hai nel sangue è la riprova di come sia possibile confrontarsi con temi tradizionali in maniera originale. Mescolando poesia e antropologia con contaminazioni weird, Gaia Giovagnoli ha saputo rinnovare il tema della colpa, della maternità e della consapevolezza del corpo, creando in Coragrotta uno specchio delle nostre anime, delle paure represse che ci tramandiamo di generazione in generazione e che si possono risolvere soltanto con l’accettazione della nostra fragilità e del nostro dolore.
*Claudia Tedeschi, Conversazione con Gaia Giovagnoli, Una / Kοινῇ – Rivista di studi sul classico e sulla sua ricezione nella letteratura italiana moderna e contemporanea, n. 2, 2021.


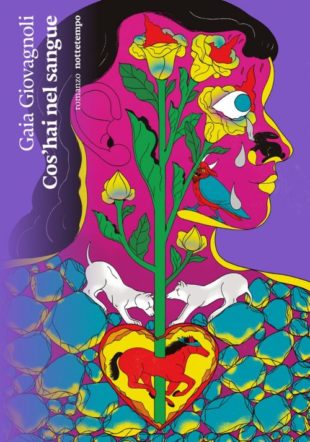



Comments