Il rosso e il nero sulla Rambla
A proposito di “Melma rosa” di Fernanda Trías
di Claudio Musso / 19 ottobre 2022
Ci sono pagine che si scrivono sul lato B della letteratura, quella che dà voce al piccolo racchiuso nello sguardo individuale. Ne è un esempio Melma rosa, scritto da Fernanda Trías nel 2019 – poco prima che iniziasse la pandemia – e da poco edito da Sur nella traduzione di Massimiliano Bonatto. A narrare è una giovane donna che osserva la propria città – che presumiamo essere Montevideo da una serie di riferimenti topografici – fermarsi e trasfigurarsi a seguito di una misteriosa pestilenza che arriva dal mare e forse dalle responsabilità umane. Tutto viene avvolto dal rosso, il colore della morte come in La maschera della morte rossa di Poe, tutto parte da alghe untrici che, grazie a un vento implacabile, diffondono le proprie spore sulla costa costringendo gli abitanti a fuggire verso l’interno o a barricarsi in casa. Intanto domina il silenzio rotto soltanto dai rumori inquietanti delle sirene di allarme, dalle ambulanze e dalle sgommate dei tassisti diventati con l’epidemia traghettatori di anime verso gli ospedali. In mezzo a questo scenario apocalittico, l’occhio della protagonista cade sull’insegna al neon dell’Hotel Palacio, a cui mancano un paio di lettere perché bruciate, che trasmette il senso di incuria e di sospensione che la città sta vivendo.
La voce narrante è molto diversa dal Principe Prospero del racconto di Poe, che si stordisce in mille distrazioni ed esorcizza quanto accade fuori. Decide invece di rimanere a Montevideo perché non riesce a pensarsi altrove e, pur indifferente alle facce che incontra, incapaci di contenere la paura, decide di indagare il senso dei propri precari legami affettivi che si sono oramai tinti di nero: non tanto il colore del lutto quanto l’assenza stessa di colore che ci rende irriconoscibili agli occhi del mondo. A questo senso di indeterminatezza la voce narrante si ribella con l’urgenza di chi vuole mettere ordine nella propria vita e capire quali sono i rapporti autentici su cui poter contare, e il suo grido di rivolta si unisce a quello di una Natura defraudata, rivelando una sensibilità ecologista che Trías condivide con altri scrittori sudamericani.
Il romanzo è apparso per molti versi profetico ed è stato frettolosamente rubricato nella letteratura sulla pandemia, un po’ come accaduto a Cecità di Saramago e altri scritti, anche per le vistose assonanze con situazioni che abbiamo tutti vissuto, tra lockdown e mascherine, ospedali intasati e complottisti. Tuttavia l’evento straordinario è solo una cornice all’interno della quale la voce narrante ripensa a sé stessa e al suo rapporto con le figure “nere” della propria vita. Si pensi al non detto che allunga le distanze tra le persone, rappresentato dal personaggio della madre, o a chi è stato un faro destinato a spegnersi come l’ex marito. Accanto a queste ci sono altre figure indeterminate: il bambino oscurato dall’etichetta della malattia a cui fa da tata e la sua stessa tata che sbiadisce nel ricordo. Tutte figure che interrogano la protagonista e i lettori riguardo a ciò che siamo disposti a dare di noi e a prendere dagli altri. Perché forse, ci suggerisce Trías, proprio quando tutto diventa scuro e non riconosciamo chi ci sta accanto, è il momento di fermarsi per fare chiarezza sul “noi e loro”, pungolati da un reale bisogno di autenticità per potersi pensare domani. Perché la pandemia, certo, passerà, ma se non agiamo prima rimarrà il dubbio su coloro con i quali abbiamo realmente a che fare ogni giorno.
Gli incontri tra madre e figlia sono di circostanza, probabilmente favoriti dall’emergenza in corso, caratterizzati da un tira e molla estenuante tra chi giudica e chi si sente giudicata, benché nessuna delle due parti intenda mollare la presa del proprio capo della fune. Una madre solo all’anagrafe che è diventata, o forse è sempre stata, un grande luogo comune, una figura estranea, alla quale ci si rivolge con frasi fatte.
C’è poi l’ex marito Max, che ha contratto il virus in una forma lieve ed è sotto osservazione da parte della scienza medica, e vive in una sorta di limbo tra guarigione e morte. Anche con lui le visite avvengono più per senso del dovere che per reale affetto, perché ormai la lingua di Max è inesorabilmente sintonizzata su stereo, mentre quella della protagonista su mono.
Le pagine dedicate al personaggio di Mauro sono tra le più riuscite del romanzo per lo scandaglio psicologico e il tentativo di superamento non solo del “rosso” ma anche del “nero”. Mauro è un bambino affetto da una rara sindrome, che presumiamo di Prader-Willi, che genitori facoltosi affidano come un pacco postale alla protagonista affinché gli tenga compagnia e lo distragga da una fame onnivora. Tuttavia lei non lo considera un malato, quanto un corpo di cui si è impossessato un impostore che si può ridimensionare sviluppando nel piccolo l’autostima e l’indipendenza. In altre parole: Mauro non è ciò che appare. Con lui la protagonista, lasciandosi alle spalle anni di diffidenza, entra nel territorio del possibile e della fantasia ipotizzando un futuro migliore. Mauro è un simbolo: più che nutrirsi sente il bisogno di predare cibo, una compulsione che è necessità di riempire un vuoto affettivo e diventa metafora di una società dal consumo sfrenato che, non trovando mai sazietà, alla fine si autodistrugge.
Infine c’è Delfa, la governante, una seconda madre, con le sue mani che avevano, nei ricordi della voce narrante, tutti i profumi del mondo, e che sapevano accarezzare la sua testa in un modo unico. Figura, quest’ultima, con cui l’autrice affronta il tema della memoria, e in cui spesso sottrae parte dei ricordi costringendoci a scavare per rimetterli insieme. Non pare un caso che la protagonista diventi lei stessa una tata. Trías non ha pertanto timore a dirci in queste pagine che chi ci sta accanto o è assente o non è come pensiamo, e chi è assente lo vorremmo vicino.
La prosa avvolgente e a tratti sinistra di Melma rosa si nutre di fasi temporali diverse che si sovrappongono: il presente della narrazione, nel momento della pandemia, con una scrittura immediata, a volte aspra, che ha fretta di registrare con lucidità e fastidio ciò che la circonda, e i ricordi del passato, tasselli in frantumi che si guardano con gli occhi della maturità e il cuore di una ragazza, il non tempo della memoria che si contrappone a un tempo oramai diventato poroso. Nel romanzo si fa anche un ampio uso del non detto, anche relativamente alle vicende passate e presenti dei protagonisti, che si traduce in un dover leggere tra le righe e nella possibilità per il lettore di darsi in autonomia delle risposte utilizzando il proprio intuito o la fantasia.
Va osservato che la Montevideo apocalittica che ci viene raccontata non è quella del 2019, ma quella ricostruita dall’autrice nella sua memoria negli anni Ottanta, quando era bambina e c’era la dittatura. Ne consegue che quello di Trías è un esercizio di nostalgia, poiché molti dei suoi ricordi sono stati prestati alla narratrice. La claustrofobia di cui è spesso vittima la popolazione rimanda a un’atmosfera opprimente, nell’inconscio collettivo, di cui non si parlava in famiglia ma che era ben presente ed è forse all’origine dell’allontanamento dell’autrice dalla sua città natale. E la figura della madre, con la quale la protagonista non riesce a parlare, potrebbe rappresentare la patria, con cui il dialogo è difficile e con la quale si stendono i silenzi. È una figura autoritaria da cui si dipende perché nutre, ma che allo stesso tempo si odia perché il prodotto che restituisce è scadente.
Come è scadente quella melma rosa che dà il titolo al libro, una sorta di carne in scatola, prodotta da carcasse animali dalla più importante industria statale, fiore all’occhiello del paese, l’unico cibo reperibile durante la pandemia. Emerge un tema decisivo per Trías, già rintracciabile nella figura di Mauro, quello del nutrimento nella sua duplice accezione: non solo cosa mangiamo o cosa siamo disposti a mangiare, senza interrogarci troppo sulla provenienza del prodotto, ma anche di cosa ci nutriamo nei rapporti interpersonali e se siamo sazi di quello che offriamo. C’è bisogno di una pandemia per capire quali sono le relazioni autentiche su cui investire tempo, energie ed entusiasmo, e che ci permettono di salvarci da un tempo pirata e non più corsaro?


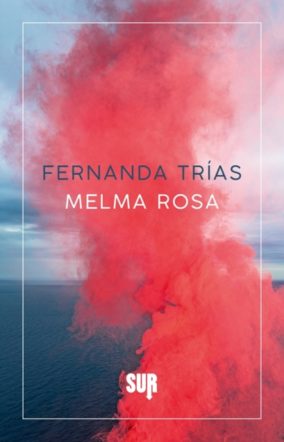



Comments