Di cosa parliamo quando parliamo d’orrore
A proposito di “Milkman” di Anna Burns
di Cristiana Saporito / 18 dicembre 2019
Ne dicemmo già, del calderone etichettato distopia. Degli stregoni folgoranti e delle loro profezie. Di tutto un ribollire di visioni. La carovana ardente dove torreggiano a varie altezze campanili chiamati George Orwell, Aldous Huxley, Philip Dick, ma anche Anthony Burgess o Antoine Volodine. E gli architetti di mondi poco auspicabili sono parecchi, probabilmente in crescita nelle più recenti uscite editoriali. Chissà perché…
Margaret Atwood, Bruno Arpaia, Louise O’Neill o Karen Thompson Walker ci propinano universi cariati dall’invasione antropocenica, laboratori del delirio dove all’improvviso un’allucinazione diventa un progetto e poi una legge. Ma, e lo accennammo proprio qualche anno fa, non c’è solo questo.
Esistono altri libri, a bruciare senza fiamme di verità solforiche. Libri in cui si capisce ineludibilmente come l’incubo, la distorsione, spesso nascano piano, in un letto di realtà comune, senza destare clamore o occupare giornali. Si nutrono delle nostre stesse cellule e si fanno pane, dettagli, ovvietà, piccolezze del quotidiano. Si fanno malattia. Cronicizzata, installata in sordina, immunodeficienza del vivere distratto.
Sono le deformità possibili, quelle descritte ad esempio da Michel Houellebecq in un romanzo, Sottomissione, come forma sottile di futuro imminente. Come creatura serpiforme che frisa e sorride intorno ai nostri passi. Sono, stavolta, le assurdità già state, immortalate da Anna Burns in Milkman (Keller, 2019, traduzione di Elvira Grassi), vincitore del Man Booker Prize.
Si racconta una storia. Ed è quello che ci aspettiamo. Ma la si estrae dal corpo dolente di quella maiuscola. La Storia di quello che sembra più di un secolo fa. E che invece è solo un pugno di decenni maldestri sparsi alle spalle. Siamo nell’Irlanda del Nord degli anni Settanta. Ci siamo, lo avvertiamo, lo palpiamo, è orbitante nell’aria col suo stormo di sintomi e segnali. Ma né il dove né il quando vengono mai esattamente menzionati.
Che anno è e in che città? Ma non sono solo le due coordinate essenziali a restare imprecisate. Ogni elemento, ogni ingrediente della composizione narrativa è privo di un nome proprio.
La protagonista è appunto sorella di mezzo, diciottenne ingoiata in una voragine di altri figli prima e dopo di lei. Non è facile esistere in quella scorza di globo, in quella infausta intersezione spaziotemporale. Il Paese è in guerra, col Paese oltre l’acqua, con gli atolli di paesi dentro lo stesso Paese. Rinnegatori contro difensori, traditori contro esercito. In un vortice che confonde i colori e disorienta chi li indossa. L’importante è puntare un nemico. E fabbricarlo diventa un mestiere. Per scampare dal mirino.
La normalità presunta è tutta condita da una selva di regole non scritte, ma totalizzanti. Decaloghi del buon agire e del buon pensare che codificano ogni aspetto del privato, mescolandolo col pubblico senza chiedersi del risultato finale. Umori, abitudini, territori dell’animo, non c’è nulla che sfugga alla catalogazione in questa storia anonima, eppure mai per un attimo indefinita.
Ed è fin troppo semplice ritrovarsi fiondati al di là del recinto. Passare il guado e non saperlo e non poter più intervenire per ricomporre l’impressione di ciò che era prima. Restare spezzati, restare per chiunque solo l’istante della frattura. Dover badare a tutto, anche ai propri aggettivi. «Insomma, “luminoso” non andava bene, ma neanche “troppo triste” andava bene, né “troppo gioioso”; in poche parole dovevi andartene in giro senza mostrare alcunché, e oltretutto senza pensare, perlomeno non più che superficialmente; ecco perché tutti tenevano i pensieri personali al sicuro nei recessi della propria mente».
Alla nostra ragazza succede di condurre un’esistenza tra tante, con un forse-fidanzato con cui ha intrecciato una forse-relazione da più di un anno. Frequenta un corso di francese, va a correre, ma questo non la protegge dal rischio di essere notata. D’altronde ha l’insano costume di leggere-mentre-cammina, d’isolarsi dal suo secolo sprofondando nella letteratura dell’Ottocento.
E magnetizza l’attenzione di chi non dovrebbe. E di chi neanche sa. Un combattente, un fuorilegge (ma da quale legge è preferibile stare al di fuori?), uomo adulto, sposato, che la adesca in auto quasi senza guardarla. Non accade niente, ma viene scelta ed è più che bastevole per proclamarla amante del Lattaio. Per additarla mentre passa e tramarle attorno un reticolo di nuove certezze dove il popolo-mantide la tiene intrappolata, giocando col suo destino come fosse un topo di pezza.
È un passaggio automatico. Essere punta dal sospetto e infettarsi in breve tempo. Il contagio non prevede difesa. Lei stessa prova a confidarsi, con sua madre, con la sua storica amica, ma il ruolo è stato già assegnato e non resta che inglobarlo. Sorella di mezzo scivola in quell’alveo di colpevolezza, disarmando il suo diritto di replica. E quel poco che aveva si sbriciola di colpo. Fino alla fine?
Questo non lo sveliamo.
Funziona comunque così, in un sistema in cui interrogare un tramonto è sconsigliabile, perché vorrebbe dire rintracciare nel cielo qualcosa d’altro oltre l’azzurro: «Se ciò che diceva era vero, cioè che il cielo là fuori – non là fuori – da qualche altra parte – poteva essere di un qualunque colore, significava che qualsiasi cosa poteva essere di qualsiasi colore […], che qualsiasi cosa poteva accadere, in qualsiasi momento […] probabilmente era anche accaduta, solo che noi non ce ne eravamo accorti. Quindi no, dopo generazioni e generazioni, padri e nonni e bisnonni, madri, nonne e bisnonne, secoli e millenni di un solo colore ufficiale e tre colori non ufficiali, un cielo pieno di colori, proprio come quello, non poteva essere ammesso».
La degenerazione è naturale, implementata come terzo atto del respiro. E l’abilità di Anna Burns è costruire un telaio sempre più asfittico, ansiogeno, irreparabile, mescolando i registri linguistici con grande sapienza e cesellando personaggi laterali per nulla secondari.
Meravigliosa la lettera scritta da “ragazza delle pastiglie”, dedita ad avvelenare chi le stava attorno per trasmettere anche agli altri il dolore del suo baratro. Quel burrone che squaderna lo stomaco e diventa terrore batterico, terrore della guarigione, di sua sorella, luminosa e gentile tanto da dover essere fermata.
E riempita del suo stesso vuoto.
Raramente un romanzo riesce a disegnare una geometria del deforme così potente e routinario, così ben camuffato, illustrato come fosse un antimodello sociale, mappatura del disagio da obbedienza costante. Archetipo anonimo. Così lontano, sperduto in un anfratto oltremare di un conflitto che poco conosciamo e comunque così accanto ai nostri giorni, spesi forse a pensare meno, a pensare leggero, a stordirsi di finti colori senza inciampare in quelli del cielo, incappottati in una dittatura confortevole a portata di palmo.
Questo succede quando si legge un libro come Milkman, esplode una mina e ciascuna delle schegge è interamente nostra, è pelle mischiata ad angoscia, è bellezza tradita a basso costo, impurità e bagliore, colpa e benedizione. Ecco il suo merito, ricordarci quanto siamo liminari, creature al confine, mezzi miserabili e mezzi eroi, a domandarci ancora quale potrebbe essere la metà di oggi.
(Anna Burns, Milkman, Keller Editore, 2019, trad. di Elvira Grassi, 456 pp., euro 19,50, articolo di Cristiana Saporito)


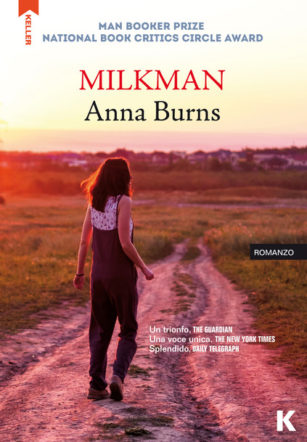



Comments