Bi (2) – La lingua più antica d’Europa
di Giacomo Sauro / 8 novembre 2012

Scrive Victor Hugo nel 1843: «Un vincolo segreto e profondo, che niente ha potuto spezzare, unisce, nonostante le frontiere diplomatiche, i trattati, e nonostante le frontiere naturali, i Pirenei, tutti i membri della misteriosa famiglia basca. […] Si nasce basco, si parla basco, si vive basco e si muore basco. La lingua basca è una patria, direi quasi una religione. Dite una parola in basco a un montanaro in montagna: prima di quella parola eravate solo un uomo per lui, adesso siete un suo fratello. La lingua spagnola da queste parti è straniera come la lingua francese. […] La Francia si prese un versante dei Pirenei, la Spagna l’altro; né l’una né l’altra hanno potuto disgregare il gruppo basco: sotto la nuova storia che da quattrocento anni si sovrappone, questo gruppo è ancora perfettamente visibile, come un cratere sotto un lago».
Victor Hugo era nato a Besançon, non lontano dal confine con la Svizzera, da tutt’altra parte rispetto ai Pirenei, ma aveva maturato una forte passione per le terre e la lingua basca. Le sue parole sono quelle di chi è rimasto affascinato da un mondo antico che riaffiora nelle sillabe di una lingua misteriosa e che è trasmesso con suoni indecifrabili. Oggi l’affresco di Hugo non possiede precisione sul piano descrittivo ma conserva tutto il suo valore nella sostanza. Dalle parti delle sette province, infatti, lo spagnolo e il francese non sono lingue straniere, se non per l’irrilevante, almeno numericamente, uno per cento di bascofoni puri. Il restante novantanove per cento della popolazione conosce almeno una delle due lingue romanze e nella maggior parte dei casi si esprime in quell’idioma. Circa un quarto degli abitanti di Euskal Herria parla il basco, ma la sua distribuzione non è uniforme: se nella costa di Gipuzkoa è la più ascoltata per strada o nei bar, nella punta meridionale di Nafarroa la lingua basca è poco più conosciuta che a Madrid. Nonostante tutto, però, il basco (indifferentemente euskera o euskara) è, come dice Victor Hugo, una patria. Niente identifica di più il popolo basco della sua lingua. È alla lingua che si lega il sentimento d’identità, più di ogni altra cosa. La stessa definizione di Euskal Herria nasce dalla lingua che vi si parla (unico caso in cui non è la lingua a prendere il nome del territorio ma il contrario) e la parola in euskera con cui sono chiamati i baschi è euskaldun, cioè «colui che sa il basco».
In un’intervista di qualche anno fa José María Satrustegi, un etnografo e membro di Euskaltzaindia, l’istituzione che tutela e regola l’euskera, aveva detto che questa lingua è la strada costruita su misura affinché il popolo basco possa esprimere la propria sensibilità e il proprio pensiero. Non c’è dubbio però che questa strada inizi con un bivio: nel mondo creato dalla lingua basca o si parla euskara o si parla erdara, dove erdara ha come referente qualsiasi lingua che non sia quella basca.
Il mistero che circonda questa lingua spiega l’esistenza del bivio; sì, perché il basco è un’isola linguistica all’interno dell’Europa e tutti gli altri idiomi gli sono estranei. Il basco infatti non è una lingua romanza, come il francese, lo spagnolo o l’italiano. Ma non è neanche una lingua slava, germanica, baltica o celtica. Non è greco e non è albanese. Si ipotizza che quando si insediò in Europa il popolo indoeuropeo (fra il V e il III millennio a.C.), dalle cui parlate si originarono tutte queste lingue, le tribù a cavallo dei Pirenei atlantici parlassero già l’euskera. Ma attenzione, perché il basco non è neanche una lingua ugrofinnica, né altaica, caucasica o semitica. Dal punto di vista linguistico è una lingua isolata, senza parentela con nessun altro idioma al mondo; e si stia pur certi che i parlanti ne sono fieri.
Nonostante siano state formulate mille teorie a riguardo, le origini della lingua basca sono ancora oggi incerte. Tra le tante ipotesi avanzate, due colpiscono per la loro carica suggestiva. La prima è quella che vede una parentela tra basco e sardo, in particolare per l’esistenza di alcuni toponimi dell’isola tirrenica che rimandano a termini baschi. La seconda, invece, fa risalire l’euskera addirittura all’età della pietra, partendo dal fatto che i termini indicanti «ascia», «zappa» e «coltello» contengono nella radice la parola haitz, «pietra». Si tratta, come già detto, solo di ipotesi sprovviste, come in molti altri casi, di un solido fondamento, ma aiutano a comprendere le ragioni di quanti, e sono molti, ritengono il basco la lingua più antica d’Europa, di quella occidentale almeno.
Il segreto che avvolge la sua nascita continua ad affascinare studiosi e non, tuttavia Koldo Mitxelena, il più grande linguista basco esistito, sosteneva che forse il vero mistero non consistesse tanto nelle sue origini quanto nella sua conservazione. Come ha potuto un idioma parlato originariamente da alcune tribù sopravvivere ai secoli, alle conquiste e alle migrazioni? Come ha fatto a resistere all’arrivo e alla diffusione di codici più potenti? Per Mitxelena l’arcano risiede nella sua astrusità, soprattutto nella sua enorme differenza rispetto al latino. Perché, diciamocelo, il basco è un inferno. Innanzitutto: i francesi e gli spagnoli non partono con nessun vantaggio al momento di impararlo; per loro come per noi è come iniziare a studiare il turco da zero. Il basco non offre punti di riferimento come le altre lingue ufficiali dello Stato spagnolo, non è uno “spagnolo francesizzato” come il catalano o uno “spagnolo portoghesizzato” come il galiziano; ne è dimostrazione la maggiore diffusione di cui godono queste lingue tra la popolazione. Avere a che fare con l’euskera significa, a prima vista, fare i conti con un lessico che, al netto dei numerosi prestiti (soprattutto latini, ma anche celtici e germanici), non fornisce alcun indizio per tentare di avvicinare il significato della parola. Tre rapidi esempi: etxe, «casa»; lagun, «amico»; eguzki, «sole». Se poi ci si addentra un poco nella morfologia verbale e nominale, si scoprirà che è una lingua infestata dai verbi ausiliari, totalmente priva di preposizioni, e che per questo si affida a venti casi per esprimere la funzione sintattica. Quasi come il latino, dove però i casi sono solo sei. Ancora con la lingua di Virgilio ha in comune il fatto che il verbo va di preferenza alla fine della frase, ma il gioco delle analogie finisce qui.
Si diceva dei prestiti e della grande influenza soprattutto dello spagnolo sulla lingua basca, ma, in parte molto minore, anche il sostrato basco ha influenzato la lingua spagnola, come per esempio nel caso di izquierda («sinistra») che viene dalla voce basca ezkerra, o di un’altra cinquantina di termini, a dire la verità meno comuni.
Un groviglio linguistico vero e proprio, quindi, che si complica ancora di più se si considera che quasi ogni paese parla un suo dialetto specifico (pare che solo la Slovenia vanti una varietà dialettale maggiore). Per cercare di sbrogliare la matassa (e sostanzialmente per avere un codice più solido e pronto a resistere al rischio d’estinzione che la modernità porta con sé), negli anni Sessanta fu creato l’euskara batua, cioè il «basco unificato», una lingua standard per l’amministrazione pubblica, per l’insegnamento nelle scuole e per i mezzi di comunicazione. Più o meno ciò che è stato tentato qualche anno fa in Sardegna con la Limba Sarda Comuna, anche se da quelle parti la coesione interna è minore e l’esperimento ha avuto fortune alterne. Tuttavia nel cuore dei Paesi Baschi, un nucleo dove i dialetti sopravvivono e che si assottiglia sempre più con il passare del tempo, non si ascolterà mai nessuno esprimersi nella varietà standard.
Al tempo della sua unificazione l’euskera in Spagna era, come tutte le altre lingue che non fossero il castigliano, fortemente discriminato dal regime franchista. Non a caso il processo di standardizzazione fu portato avanti nei Paesi Baschi francesi. Una volta terminati i quasi quarant’anni di dittatura di Francisco Franco, durante i quali il basco fu bandito dalle scuole e la sua sopravvivenza garantita esclusivamente dall’uso familiare, il principio di salvaguardia della diversità linguistica e culturale tornò a essere ascoltato. Oggi nella penisola iberica l’euskera è lingua ufficiale, insieme allo spagnolo, nella Comunidad Autónoma Vasca e nella Comunidad Foral de Navarra (solo nella zona linguistica nord, in verità; nella zona centrale è comunque tutelato, mentre in quella sud è sostanzialmente assente). In Francia, invece, sin dai tempi della Rivoluzione, il francese è l’unica lingua ufficiale dello Stato. Il basco, così come il bretone, l’occitano o il corso, è considerato una lingua regionale, il cui studio è ammesso nelle scuole, insieme ad altre piccole misure di tutela, ma per cui non è previsto alcun riconoscimento istituzionale.
![]()
Nell’intervista cui si faceva riferimento prima, Satrustegi sosteneva anche che se l’euskera fosse stato la lingua della Germania, oggi sarebbe il monumento più grande d’Europa, maggiore di qualunque costruzione in pietra, e che se il popolo basco è detentore dell’idioma più antico d’Europa, la sua perdita sarebbe un dolore per tutti i suoi membri. Si provi adesso a entrare in questa prospettiva: se si accetta che in questa zona a cavallo fra Spagna e Francia viva ancora, dopo molti secoli, un popolo territorialmente diviso che sente una propria identità nazionale trasmessa dalla lingua che solo esso parla, allora si può iniziare a capire la portata del conflitto basco.
Nonostante il piano linguistico sia separato da quello politico, è innegabile che il conflitto investa anche il primo. Nel complesso di Euskal Herria i bascofoni sono consapevoli della propria condizione di minoranza e vedono la propria crescita come l’unico strumento per sopravvivere nel mondo globalizzato. Dall’altra parte, chi non parla euskera avverte questo atteggiamento come un’ossessione tenebrosa per imporre un monolinguismo basco. Non giova certo alla distensione l’identificazione della lingua basca con il nazionalismo violento avvenuta negli ultimi quarant’anni, mentre bisognerebbe partire da quella convinzione che, nonostante tutto, è prevalente in entrambe le posizioni: il bilinguismo basco-spagnolo o basco-francese è una ricchezza culturale non da poco.
Va anche aggiunto che la destra spagnola, sempre impegnata a sottolineare la priorità della cultura castigliana, alimenta il lato vittimista di una parte del movimento basco.
A ironizzare su questo atteggiamento ci hanno pensato, come per altri temi delicati dei Paesi Baschi, i Lendakaris Muertos, un gruppo punk di Iruñea. Il nome è un omaggio ai Dead Kennedys (lehendakari è il termine in lingua basca con cui viene comunemente identificato, anche in spagnolo, il presidente della Comunidad Autónoma Vasca) e lo stile è caratterizzato da pezzi brevi, ritmi serrati e testi taglienti. Nella canzone Se habla español, contenuta nell’album omonimo del 2006, è beffardamente descritta la progressiva scomparsa dell’uso del basco a favore dello spagnolo. Il ritornello è un intraducibile gioco di parole basco-spagnolo in cui si parafrasa una canzoncina per aiutare i bambini a imparare l’euskera, mentre il riferimento alla polizia, vista in un certo ambiente come il braccio armato dell’oppressione, è l’ultimo affronto goliardico.
Se habla español en Euskal Herria Si parla spagnolo nei Paesi Baschi
se habla español más que en Andalucía si parla più spagnolo che in Andalusia
se habla español en Euskal Herria si parla spagnolo nei Paesi Baschi
habla más vascuence hasta la policía. parla di più in basco persino la polizia.
Nos solidarizamos con el pueblo saharaui Siamo solidali con il popolo sahraui
pero de los de aquí ya no se acuerda nadie ma della gente di qui non si ricorda nessuno
el oso panda pronto se extinguirá il panda presto si estinguerà
y ya sólo lo hablamos en la intimidad e ormai lo parliamo solo nell’intimità
ya sólo se usa para intentar ligar ormai si usa solo per provare a rimorchiare
pedir 3 cervezas o el pan de hoy, oi, oi! ordinare 3 birre e il pane di oggi!
Los que no lo aprenden no tienen perdón Chi non lo impara è imperdonabile
los que no lo usamos iremos al paredón. chi di noi non lo usa sarà fucilato.
Agarra esa manzana
ikatza cabrón
mujer-andrea
y tú eres un mamón.


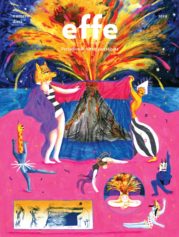


Comments