Libri
Il filo d’Arianna del linguaggio
La letteratura ci orienta nel caos del mondo
di Claudia Cautillo / 27 maggio
Persi nel caos del mondo, nel groviglio della società troppo satura d’informazioni in cui oggi viviamo, sono andate smarrite le coordinate necessarie a un orientamento che spieghi e renda intelligibile il suo disgregato overload di contenuti, sorta di paralizzante pletora sensoriale che, così come l’immagine opposta all’interezza e alla linearità propria del labirinto – dal greco λαμβάνω (lambàno) che significa prendere ma anche assumere su di sé o patire una pena, un castigo e ρινάω (rinào) che sta per inganno, trappola – si presta al significato tanto dell’intraprendere consapevolmente un percorso frammentato e contorto, quanto dell’esserne involontaria vittima.
Se in ciascun caso l’etimo, che indica ciò che non si può cogliere con uno sguardo solo, cioè che non schiude il suo cammino verso soluzioni facili e immediate, è raffigurazione di difficoltà e smarrimento che tuttavia contiene in sé la propria chiave di volta, anche quella paralisi del pensiero, al contempo misteriosa ma evidente, che è il disagio della contemporaneità, alla pari di un labirinto include la possibilità di una strada accidentata ma percorribile, solo apparentemente senza via d’uscita.
Seguendo l’ermeneutica di Gadamer è il linguaggio – dunque la letteratura – il filo d’Arianna in grado di portarci fuori dai meandri dispersivi dello strabordare delle impressioni, permettendo di ristabilirne i nessi ovvero di dar loro un senso. Contro il collasso percettivo di una società che non sa più parlare, perduta nel flusso continuo del pluralismo della comunicazione, ne costituisce lo strumento privilegiato che ci offre la speranza del riscatto dalla massa oleosa del rumore quotidiano, restituendoci la capacità di leggere, ordinare ed esprimere ciascuno la nostra personale visione delle cose.
Questa funzione, di livello e qualità insostituibile, è resa possibile perché, come osserva Barthes in Il grado zero della scrittura, non vi è letteratura senza morale del linguaggio, senza cioè quella spina dorsale, quel «midollo del leone» di cui parla Calvino in Una pietra sopra commentando l’urgenza, per comprendere la nostra epoca, di vivere sulla linea del fuoco: «noi crediamo che l’impegno politico, il parteggiare, il compromettersi sia, ancor più che dovere, necessità naturale dello scrittore d’oggi, e prima ancora che dello scrittore, dell’uomo moderno».
Ma la letteratura offre infiniti percorsi di orientamento nel magma della realtà, diversi ciascuno per ogni autore. C’è chi, come Faulkner, affida al complesso intrecciarsi di toni e stili della scrittura, che vanno dall’iperbolico all’elementare, quella capacità morale di accedere all’essenza delle cose, di forzare il loro segreto. Diversamente da Hemingway, che trovava il suo stile fastidiosamente retorico – basti confrontare L’urlo e il furore a Per chi suona la campana – il linguaggio per Faulkner è corrispondenza metaforica che non si fa carico di essere presenza attiva che agisce direttamente (politicamente, si potrebbe dire) sulla coscienza del lettore.
Posizione intermedia tra le due è la forza salvifica e semplificatrice della parola di cui scrive Musil in L’uomo senza qualità: «la legge di questa vita a cui si aspira oppressi, sognando la semplicità, non è se non quella dell’ordine narrativo, quell’ordine normale che consiste nel poter dire: “Dopo che fu successo questo, accadde quest’altro”. Quel che ci tranquillizza è la successione semplice, il ridurre a una dimensione, come direbbe un matematico, l’opprimente varietà della vita; infilare un filo, quel famoso filo del racconto di cui è fatto anche il filo della vita, attraverso tutto ciò che è avvenuto nel tempo e nello spazio! Beato colui che può dire; “allorché”, “prima che” e “dopo che”! Avrà magari avuto tristi vicende, si sarà contorto dai dolori, ma appena gli riesce di riferire gli avvenimenti nel loro ordine di successione si sente così bene come se il sole gli riscaldasse lo stomaco».
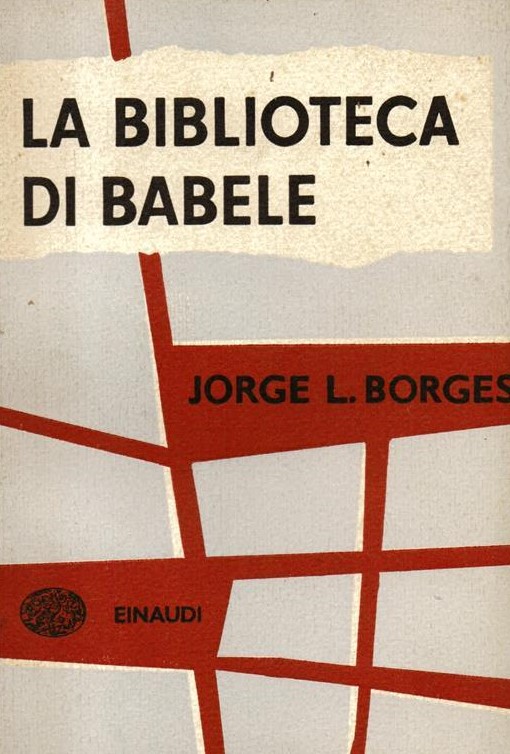
Prospettiva agli antipodi dell’universo letterario di Borges, distaccato e ironico. Sorta di mandala incompiuto, il ginepraio ingannevole delle infinite combinazioni di frasi prive di senso di La biblioteca di Babele, che senza centro si diramano dalle sue sale esagonali, è insieme modello di conoscenza quanto constatazione dell’impossibilità di una sintesi del sapere, un ordine di significati che, nella realtà povera di relazioni chiare tra le cose in cui siamo oggi immersi, ci orienti nel distinguere la verità dal suo opposto.
Simile alla topografia ortogonale della sua Buenos Aires, frastagliata e imprevedibile, il linguaggio per Borges dunque mostra, non significa. Indica senza spiegare. È struttura labirintica che, con dissacrante paradosso, si fa forza dissestante che anziché tendere alla linearità accetta l’inesplicabilità, il perdersi come destino. Per questo descrive la Storia universale dell’infamia «ambigui esercizi di prosa narrativa» perché, convinto che la proprietà generale del cosmo sia la vacuità, l’apparenza, una sterminata superficie di immagini accavallate senza nesso né significato, è vano tentare di costringere in una forma compiuta la caleidoscopica cacofonia delle impressioni, di dar loro un ordine attraverso la parola.
Ancora diversamente Proust, – nota Spitzer – con il ritmo sinuoso delle sue frasi colme di incisi e parentesi, pur sembrando presentarci la cangiante confusione e l’infinita complessità del reale come un labirinto in cui l’uomo rischia di smarrirsi ed esserne sopraffatto, ci rende invece possibile una spiegazione del mondo che, nel suo ricondurre il molteplice all’uno, ci restituisce l’universale di «una grande pace, un senso di eternità».
La vita, così inconcepibile senza le parole, nell’immenso edificio dell’opera proustiana trova forma e significato non solo per mezzo degli ampi e complessi periodi della struttura sintattica, ma soprattutto grazie alla metafora metonìmica o diegetica, figura centrale della retorica ampiamente utilizzata nella letteratura moderna – oltre a Proust basti pensare, a titolo di esempio, a Poe, Virginia Woolf e Joyce – che Michel Deguy definisce il genere supremo, la figura delle figure.
Per metafora, dal latino methafora e dal greco μεταϕορά (metaforà) che vuol dire trasferimento si intende, come noto, la trasposizione simbolica di un termine proprio con uno figurato. Per esempio le spighe ondeggiano come se fossero un mare oppure sei un fulmine per dire sei veloce come se fossi un fulmine. Con metonìmia, dal greco μετωνυμία (metonimìa), cioè scambio di nome, si indica invece il nome della causa per quello dell’effetto, ad esempio vivere del proprio lavoro; della materia per l’oggetto, cioè sguainare il ferro; oppure del contenente per il contenuto bere una bottiglia; e anche del simbolo per la cosa non tradire la bandiera, ecc. Dunque il procedimento metaforico opera per somiglianza, mentre quello metonìmico per contiguità.
La metafora metonìmica, anche detta diegetica, dal greco διήγησις (diegèsis) ovvero racconto, è orientata alla diegèsi, cioè all’universo spazio-temporale della narrazione. Questo significa che è fondata sulla contiguità –spaziale, temporale, psicologica, ecc. – di più sensazioni. In sintesi la metafora viene ad agire attraverso quel concetto di contiguità, cioè di rappresentazione simultanea di azioni parallele, proprio della metonìmia, che abolisce la distanza tra passato e presente e unisce avvenimenti disgiunti nello spazio, dove le cose sono insieme vicine e lontane.
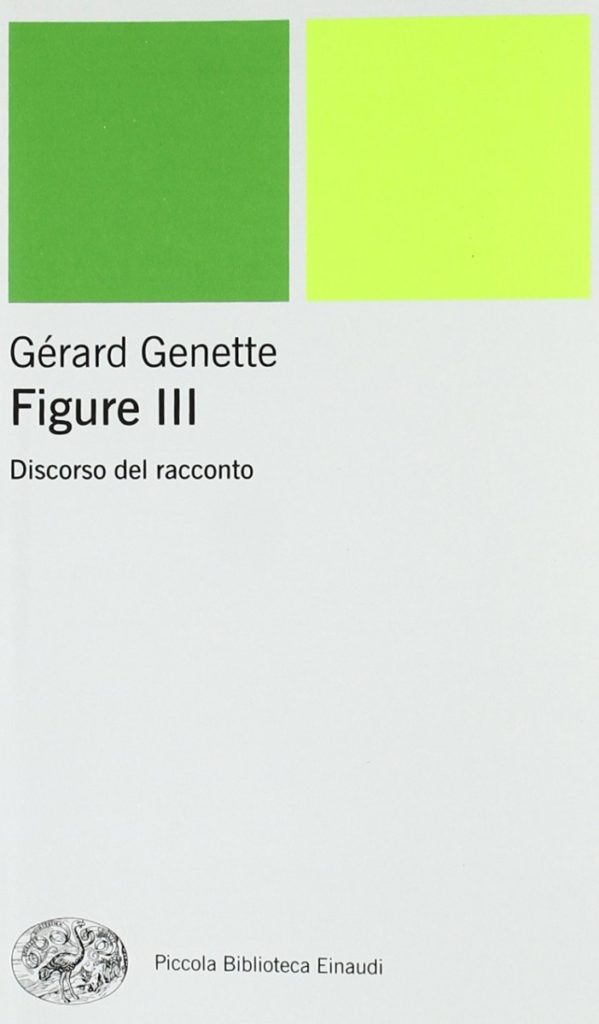
Ecco allora che nel topos del campanile camaleonte, individuato da Genette in Figure III, la ragione della scelta delle metafore proustiane riposa interamente sul pensiero del bagno, mentre la contiguità del mare orienta verso un’interpretazione acquatica l’intero lavoro della fantasia metaforica: «Saint-Mars, del quale, in quei giorni ardenti in cui si pensava soltanto al bagno, i due antichi campanili d’un rosa salmone, dalle tegole a losanga, lievemente pendenti e come palpitanti, parevano vecchi pesci aguzzi, embricati di squame, spumeggianti e rossastri, che senza parer muoversi, s’alzassero in un’acqua trasparente e azzurra».
Ma l’importanza fondamentale della metafora metonimica non è soltanto quella di rendere il tempo simultaneo, di operare un’analogia tra due o più situazioni. Così come il vero miracolo proustiano non è tanto il fatto che una madeleine inzuppata nel tè abbia lo stesso sapore di un’altra madeleine inzuppata nel tè, e ne desti il ricordo, ma piuttosto che la seconda resusciti con sé una stanza, una casa, giardini, un’intera città, cioè consista in quel fenomeno di seconda vista, nel movimento d’anamnesi, che è l’irradiazione metonimica liberata da tale semplice analogia.
Quindi non solo metafora, non solo analogia ma, attraverso le affinità segrete ridestate a questo modo, soprattutto restituzione di senso, collegamento tra le disiecta membra del mondo. Si può perciò dire che senza metafora niente paragone, niente spazializzazione del tempo, niente ricordi. Però senza che la metafora sia innestata sulla metonimia, niente concatenazione di analogie e di ricordi, niente epifania della realtà.
Tuttavia, se la metafora diegetica è un modo per fare chiarezza nella disarmante ressa di dati della realtà, il linguaggio, aperto a innumerevoli declinazioni, si muove di continuo con nuvolosa leggerezza, immaginando. Ed è proprio per questo suo manifestarsi sotto forma di una serie imprevedibile e sempre rinnovata di risposte, diverse per ciascuno scrittore, che la letteratura è l’invisibile filo d’Arianna disperso, ma presente, nel labirinto della totalità.



 www.flaneri.com
www.flaneri.com