Libri
Edgar Morin, le parole per parlare di cinema
«Confrontare l’umanità con la propria immagine»
di Elisa Carrara / 14 ottobre
Bisognerebbe leggere Edgar Morin quando si è molto giovani e la vita sembra un insieme di infinite scelte. E poi rileggerlo quando si è molto grandi e la vita sembra un insieme di infinite scelte sbagliate.
La lezione più importante che il filosofo francese ci ha regalato in questi cento anni, infatti, è imparare a comprendere il mondo, le persone, noi stessi. Per farlo occorre ricordare che «vivere è affrontare continuamente l’incertezza» e che non bisogna temere la complessità: «Quello che chiamo pensiero complesso è il pensiero che vuole superare la confusione, la complicazione e la difficoltà di pensare, con l’aiuto di un pensiero organizzatore: separatore e reliante», come scriveva nel suo Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione (Raffaello Cortina, 2015).
Nemico del sapere specializzato, delle divisioni in discipline, del distacco tra cultura umanistica e scientifica reso incolmabile dalla scuola (o quantomeno da un certo modo di pensare e strutturare la scuola), Morin si affida da sempre alle parole, al loro potere, alla loro capacità di evocare, spiegare, unire.
Non è un caso che Anna Battaglia, traduttrice dell’edizione italiana della raccolta Sul cinema. Un’arte della complessità (Raffaello Cortina, 2021) dedichi una breve ma interessante digressione proprio sul gioco linguistico intrapreso dall’intellettuale francese. E alle responsabilità inevitabili, per chi traduce, di restituirne i significati profondi: Morin è un inventore di parole, le costruisce, allo scopo di conciliare gli opposti, sovrapporre forma e contenuto, collimarli e annullarne i confini. Lo ha fatto, in passato, con il termine relianza, divenuto un caposaldo del suo pensiero. Ora, in questi scritti sulla settima arte, troviamo esempi meno celebri ma altrettanto godibili: crucidité (altra invenzione) e il gioco di assonanze, a proposito dell’opera di Michelangelo Antonioni, tra fait divers e faits d’hiver, impossibile da rendere in italiano, ma ben spiegato dalla nota della traduttrice.
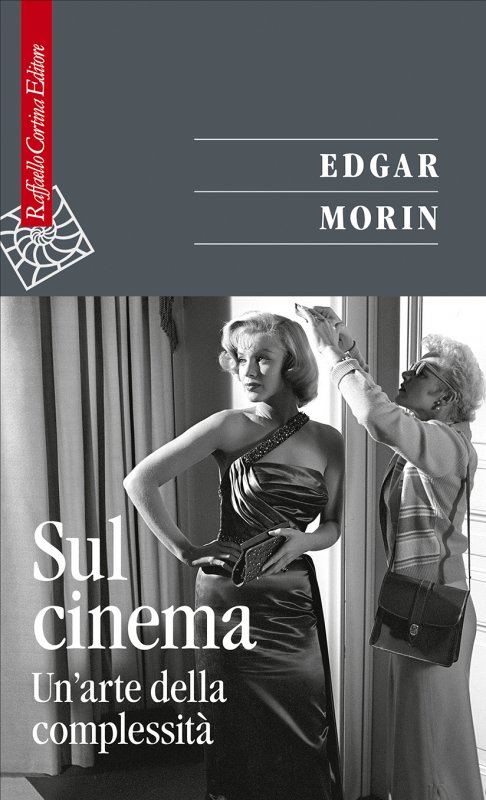
Non deve stupire che in una raccolta dedicata al cinema si presti così tanta attenzione al linguaggio: Morin, come sua abitudine, è interessato a dilatare la riflessione sull’arte cinematografica affrontando lo studio attraverso le chiavi dell’antropologia e della sociologia. E utilizzando l’arma della buona scrittura.
Esperienza estetica e fatto sociale, arte e industria, cultura e divertissement: secondo Morin il cinema è lo strumento essenziale per comprendere l’uomo e la società e, allo stesso tempo, il riflesso di entrambi: «lo spettatore di cinema è posto davanti a giochi di luce e ombra. Sono proiezioni – identificazioni che danno corpo ed esistenza a personaggi e trasformano lo schermo in finestra aperta su un mondo vivo», scrive nel 1961 a proposito di quello che chiama stato estetico-ludico, e aggiunge nel 2018: «Si tratta comunque sempre di confrontare l’umanità con la propria immagine, per provocare una scossa, uno choc dal quale possa nascere una riflessione, una presa di coscienza».
Occorre dunque «far luce sul cinema attraverso la società e nello stesso tempo far luce sulla società attraverso il cinema», scrive nel 1954: bisogna però trovare un metodo, perché cinema e vita reale sono perciò inscindibili: l’esperienza del film, nonostante la sua capacità di alienarci dal mondo, «ci sveglia alla comprensione degli altri», come ricorda in Insegnare a vivere.
Sono le stesse curatrici di Sul cinema, Monique Peyrière e Chiara Simonigh, a spiegare il faticoso lavoro di ritrovamento, raccolta e sistematizzazione di questi articoli e saggi, inediti, scritti da Morin tra i primi anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo, nel periodo in cui le sale conoscevano la gloria e poi, rapidamente, il declino: il percorso scelto ignora l’ordine cronologico e va dall’universale al particolare, dalla dimensione intima a quella sociale, attraverso le opposte e speculari superfici entro le quali la riflessione si estende (mimesi/catarsi; archetipi/stereotipi; eros/thanatos; felicità/crisi; cinema/essai).
Sarebbe impreciso, però, considerare quest’opera esclusivamente un manuale di ricerca, destinato solo a chi sappia destreggiarsi fra la terminologia scientifica, perché il fascino di Morin, del suo pensiero, e ciò che ne ha decretato anche il successo editoriale negli anni, sta nella capacità di fluttuare sulle cose, di spiegare l’inspiegabile, di fornire le parole per comprendere.
Edgar Morin ama il cinema, le sue pagine restituiscono la profondità e la forza di tale sentimento: lo fa in particolar modo addentrandosi nell’analisi filmica, quando, per esempio, indaga l’invenzione della good bad girl nella narrazione cinematografica; quando paragona il genere poliziesco ai drammi shakespeariani; quando esamina il mito Marilyn e l’oriente raccontato da Hollywood; quando si inabissa nel mondo oscuro di Ingmar Bergman o spiega il successo catartico e paradossale della figura del mendicante: in quei passi la scrittura di Morin sembra condurci per mano in un territorio familiare: «Come Pavese nel romanzo, Antonioni è il regista del dolore segreto. La sua Italia è quella del Po nei dintorni di Ferrara. Il suo film avanza lentamente, su una grande pianura nuda, come il Po, sotto un cielo uniformemente grigio. […] Tutto il film si svolge tra il momento in cui un uomo è colpito a morte e il momento in cui cade». Bastano queste poche righe, scritte nel 1959 in un articolo dedicato a Il grido, opera tra le più intense (e meno apprezzate da una certa critica dell’epoca) del regista ferrarese, per capire l’abilità di Morin nell’osservare, scomporre, riunire gli oggetti della sua indagine attraverso una scrittura tersa e avvolgente.
Chi ama il cinema sa che non si tratta mai di un amore contemplativo, bensì di un bisogno profondo di capire, sviscerare, comprendere il mondo e sé stessi, come ci ha insegnato anche François Truffaut nella sua lunga intervista ad Alfred Hitchcock (Il cinema secondo Hitchcock, il Saggiatore, 2014). Ebbene, il viaggio intrapreso da Morin in questi scritti conserva la stessa innocente, insaziabile ingordigia con cui guardiamo un film, ma mantiene intatti il rigore e la complessità a cui il filosofo francese ci ha abituati.



 www.flaneri.com
www.flaneri.com